Cosa passa nella testa dei più piccoli quando sono testimoni di eventi catastrofici come il sisma che ha colpito l’Italia centrale il 24 agosto? Lo abbiamo chiesto a Francesca Ciotti, psicologa del Policentro Pediatrico di Milano
Per chi non ha vissuto direttamente il dramma, col tempo sbiadiranno le immagini della devastazione che si è consumata la notte del 24 agosto fra Lazio, Marche e Umbria con il terremoto che ha ucciso 295 persone. Terremoto che, invece, sarà lo spartiacque dell’esistenza degli oltre 5mila sfollati, fra cui molti bambini e ragazzi. Abbiamo cercato di capire che impatto abbia una catastrofe del genere in menti così giovani e in formazione: ce lo ha spiegato la dott.ssa Francesca Ciotti, psicologa milanese e collaboratrice del Policentro Pediatrico.
Dottoressa, in caso di evento traumatico, c’è un modo diverso di vivere la paura in base all’età?
Innanzi tutto dobbiamo spiegare cos’è un evento traumatico: per grandi e piccoli un evento traumatico è qualcosa che rappresenta la rottura di ciò che in psicologia definiamo la “continuità del sé”. La rottura, cioè, di tutto quell’insieme di abitudini, persone e luoghi che compongono la vita quotidiana. Una rottura tale da farci dire che nella nostra vita c’è un “prima” e un “dopo” rispetto a quell’evento. In caso di un evento catastrofico, bambini e adulti sviluppano subito un senso di impotenza e vulnerabilità di fronte a una minaccia oggettiva. E la sfera emotiva diventa preponderante: alcuni studi scientifici hanno dimostrato che ci sono dei cambiamenti fisiologici nel cervello dopo un trauma: chi ne subisce uno, ha una iperattivazione delle aree sottocorticali del cervello, che son quelle dell’emotività, rispetto alle aree corticali del raziocinio. Tradotto: la persona è sempre in uno stato di allerta.
Che impatto c’è sui bambini? Cosa passa nella loro testa?
Nel caso di un terremoto dagli esiti devastanti come quello in Italia centrale, i bambini si trovano improvvisamente di fronte a una situazione di perdita dei loro punti di riferimento: persone, luoghi e cose. Con una caratteristica fondamentale: a loro manca la possibilità di dare un significato a quello che succede, perché non hanno ancora sviluppato gli strumenti cognitivi e le esperienze utili a comprendere. In un bambino piccolo c’è molta confusione, invece un pre-adolescente o un adolescente hanno già altre abilità logiche.
Durante un collegamento di Radio 1 due giorni dopo il terremoto, l’inviato ha intervistato un’operatrice del Telefono Azzurro che ha spiegato l’attività che stava svolgendo con bambini di diverse età, e cioè “la scuola che vorrei”. Mi ha colpito molto il fatto sono stati i bambini a voler parlare con il giornalista, interrompendo la volontaria per raccontare le loro idee, tra una scuola piena di brillantini e colorata di rosa, e una dove ci fosse motoria e immagine e poi basta, perché le altre materie non sono interessanti.
I bambini ci stupiscono tantissimo per come affrontano, qualche volta – ci sembra – in modo rapido, le situazioni difficili. Quella voglia di parlare, e tanto, di usare colori sgargianti è il loro modo di esorcizzare la paura e sconfiggere “il brutto”. Evidentemente, tramite il lavoro condotto dall’operatrice, quei bambini si sentivano bene e liberi di buttare fuori la loro emotività anche con una persona sconosciuta come il giornalista. Proprio perché in queste fasi post evento si vive in un tumulto di emozioni, l’adulto deve affiancare il bambino in maniera che senta che c’è qualcuno pronto ad ascoltarlo e ad accogliere le sue paure e incertezze.
Invece, nel “mentre” come è opportuno reagire?
Sarebbe meglio che il genitore non andasse nel panico, ma anche se non riesce a controllare la propria paura la regola resta sempre una: parlare e spiegare ai bambini cosa succede. Un bambino, infatti, si spaventa di più guardando la reazione della mamma e del papà che dell’evento in sé. A domande come “mamma che succede? Perché piangi?” non si deve mai rispondere “Non ho niente, non è successo niente”. Negare non è la soluzione più adatta: un bambino coglie molto più di quello che l’adulto crede. Spesso gli adulti tendono a celare le realtà più dolorose agli occhi dei bambini in quanto mossi da un naturale istinto protettivo nei loro confronti. Ed è comprensibile essere in difficoltà a volte a “trovare le parole giuste” .
Nelle ore immediatamente successive al terremoto, il Telefono Azzurro ha diffuso ai media una sorta di decalogo del comportamento da tenere con i bambini. I consigli si possono riassumere con quattro concetti chiave: tranquillità, ascolto, semplicità e attenzione ai segnali di ansia. è corretto?
è un giusto riassunto. L’adulto deve aiutare il bambino a trovare un senso a quello che è successo, a mettere insieme i pezzetti del puzzle, ma con i tempi del bambino stesso. Ci possono essere quelli che fanno subito decine di domande e altri che si chiudono: se l’adulto li sollecita troppo, c’è il rischio che si chiudano ancor di più. Bisogna avere pazienza ed essere pronti a rispondere alle loro domande, anche molte volte alla stessa. Attenzione poi al fatto che i bambini, soprattutto quelli in età scolare, spesso fanno domande su altre persone, che è la dinamica tipica del parlare di altri per avere risposte su di sé. Come, ad esempio, chiedere “perché il mio amico ha perso tutto?”, “perché la sua mamma è in ospedale?”. Per quanto riguarda gli adolescenti il discorso è ovviamente diverso: non è escluso che nel loro comportamento compaia dell’aggressività, un modo per riaffermare con forza la loro ricerca dell’indipendenza dai genitori – tipica di questa fase – tramite il rifiuto di aiuto. Ma può anche capitare che l’evento traumatico li porti a regredire sviluppando una nuova dipendenza emotiva dal genitore.
Nella più drammatica delle ipotesi, un evento catastrofico può rendere alcuni bambini orfani. Come aiutarli?
Questo caso è la perdita totale dei loro punti di riferimento: è meglio che la comunicazione al bambino sia fatta da un parente o comunque da una persona a lui vicina, in modo semplice e con modalità diverse a seconda dell’età. Ma con una raccomandazione: non mentire mai, ad esempio dicendo il papà è dovuto partire ma tornerà. Prima o poi la bugia sarà scoperta, rendendo difficile per il bambino riacquistare fiducia, ma anzi: si crea il terreno fertile per fargli sviluppare un senso di colpa. Nel momento in cui un adulto, infatti, non è onesto con un bambino, non risponde in modo positivo alle sue paure e crea il presupposto affinché l’angoscia, che naturalmente la perdita di un genitore provoca, diventi nel tempo un fantasma molto difficile da scacciare.
Ha detto che servono modalità diverse a seconda dell’età, quali?
Bisogna tenere in considerazione l’evoluzione della percezione della morte da parte dei bambini. Cercando di semplificare: fino ai 2 anni non hanno chiaro cosa essa sia, quindi in caso di perdita di un genitore, “sentono” che non c’è più, che un legame affettivo si è rotto. Dai 3 ai 5 anni, in cui cominciano a sviluppare la cosiddetta “costanza dell’oggetto”, raggiungono la consapevolezza che mamma e papà sono persone sempre presenti: dovessero venire a mancare, i bambini percepiscono chiaramente la perdita ma la morte è per loro ancora qualcosa di magico e, soprattutto, di temporaneo. Nella prima età scolare, anche perché cominciano a studiare un po’ di scienze, i bambini capiscono che è un processo irreversibile, ma lo considerano normale solo per gli animali e le persone anziane. Ormai alle medie, invece, il concetto è ben chiaro e definito ed è a questa età che alla perdita si accompagna un senso di angoscia.
Le immagini di catastrofi come il terremoto in Italia centrale possono avere un impatto anche sui bambini che ne sono testimoni indiretti, per esempio guardando il telegiornale. In che modo gli adulti devono fare da filtro?
Per i bambini c’è differenza tra vedere in tv una casa “rotta”, che sì è impressionante, e vedere invece la sofferenza delle persone: è questa la cosa che li colpisce di più. Se i bambini sono in età scolare, è probabile che sappiano cosa sia un terremoto perché lo hanno studiato, mentre a un bambino più piccolo va spiegato che questi sono eventi naturali che possono succedere. Bisogna rassicurarli, dicendo che le persone che ora sono in difficoltà stanno ricevendo aiuto. Così come, dovesse capitare a loro, ci sarà sicuramente qualcuno che verrà ad aiutarli.
Un’ultima domanda: si sta lavorando affinché i bambini e i ragazzi colpiti dal terremoto comincino la scuola con regolarità la prossima settimana. Come sarà?
Per loro sarà un segno importante di continuità con la vita di prima. E sarà un’occasione fondamentale di aggregazione e di condivisione di quanto hanno vissuto e stanno vivendo, sia fra di loro che con gli insegnanti. Insegnanti che dovranno prestare attenzione a eventuali segnali psicofisici ed emotivi di disagio o di malessere: in questa situazione lo stress scolastico può accumularsi a quello post traumatico.
Dopo il terremoto in Italia centrale, si è tornato a parlare di prevenzione e il Governo sta lanciando il progetto “Casa Italia”, che riguarderà l’adeguamento antisismico del Paese. Ma la prevenzione passa anche attraverso il nostro comportamento: se sappiamo come reagire a un evento come un terremoto o un’alluvione, sappiamo come essere di aiuto a noi stessi e agli altri. Uno strumento utile è senza dubbio il portale “Io non rischio” della Protezione Civile nazionale: consultatelo.







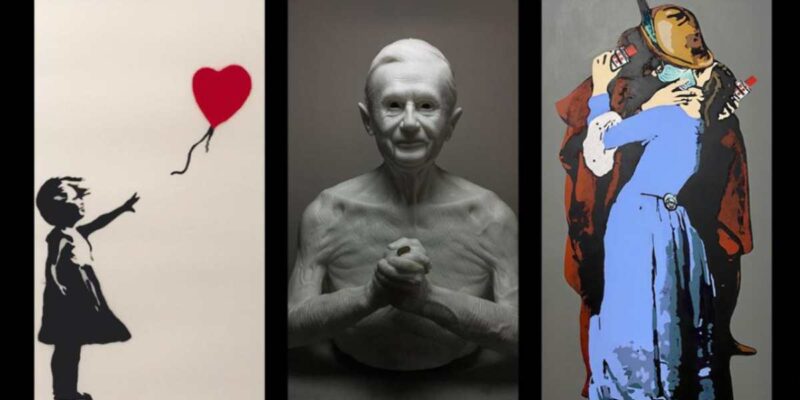






0 commenti